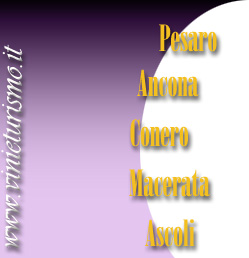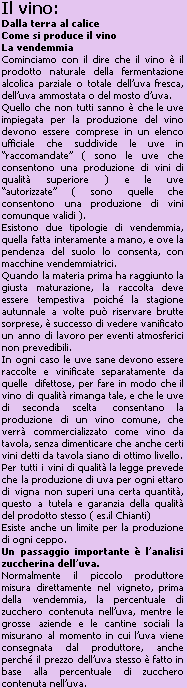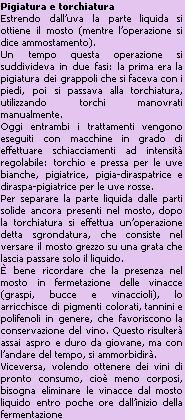|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
Il Vino novello Il vino novello che ha sostituito quello che era il vino nuovo, un' esempio di come il consumo moderno abbia ridato vita alle tradizioni del nostro Paese. Da alcuni anni entra in commercio il 6 di Novembre , come il primo vino della vendemmia da poco conclusasi. Il costume di acompagnarlo ai frutti delle stagione , in particolare le castagne , si perde in un passato lontanissimo di cui faceva parte anche la tipica festa "MEZZADRILE" di San Martino che cade pressappoco negli stessi giorni. Oggi invece il Novello una risposta che segue le tendenze dei consumatori alla ricerca di novit e qualit: novit, perch aggancia la stagione precedente a quella in arrivo, consentendo ai produttori di dare ai vini dell'annata la giusta maturit ed il giusto invecchiamento, qualit, perch la vinificazione viene attuata con tecniche particolari che esaltano i profumi e gli aromi del mosto. Sangiovese, Montepulciano e Lacrima sono i vitigni pi utilizati. Nel 1988 erano almeno trenta le case vinicole regionali che producevano circa 500.000 bottiglie , nel 2000 la produzione aumentata del 6% . Negli ultimi anni la tipologia novello st entrando sempre pi a far parte dei disciplinari di produzione delle Doc, anche grazie alla ricerca enologica sviluppata dall' Assam, AGENZIA della REGIONE MARCHE in AGRICOLTURA che, attraverso i suoi centri operativi e la Cantina di Camerano, ha posto attenzione alla sperimentazione enologica e viticola di questo come gli altri prodotti innovativi e di qualit, fornendo a coltivatori e produttori le indicazioni utili per ottimizzare e qualificare al massimo la tipicit Marchigiana. Gli Spumanti: Le Marche hanno una buona confidenza con lo spumante ed oggi non sono pi soltanto i tradizionali vini Verdicchio e Vernaccia di Serrapetrona a dar origine a tale produzione. Esperimenti riusciti sono avvenuti anche con altri vini Marchigiani, dal Falerio al Colli Maceratesi e, con successo, con uve Montepulcuiano, vitigno di base del Rosso Conero, e con uve Passerina come previsto dalla nuova DOC Offida . Gli scrittori di enogastronomia accennano ad antichissime origini dello spumante Italiano nel territorio Marchigiano . Una radice storica esiste : il primo Champenois italiano sarebbe nato nelle Marche e il musicista G. Spontini lo avrebbe bevuto nella sua Maiolati (nei Castelli jesini) addirittura nel 1805, cinquant'ani prima che il Piemonte avvesse dato vita al celebre prodotto. Maggior fondamento ha una lettera inviata dall'amministratore dei Beni della Casa Ducale di Leuchtemberg in Fano al Gonfaloniere della citt di Jesi. In essa si attesta che dal 1843 al 1847 l'amministratore Ubaldo Rosi si occup della vinificazione di spumanti "alla maniera del vero champagne" e si chiede l'esenzione dal dazio di bottiglie di vetro nero di Francia per vini spumanti. Altre testimonianze vengono da Loreto, dove un tale sign. Spalazzi, fin dal 1849, prov e riprov fino ad ottenere un vino "che senza avere nulla dell'imitazione ha tutti i pregi e le perfezioni dello Champagne Francese". Da notare che, in Italia, il termine " Champenois" ( che indica un metodo di rifermentazione in bottiglia ) stato sostituito dall'agettivo "Classico" . Tale dizione distingue il procedimento dagli altri, in particolare dallo "Charmat" che prevede la maturazione in autoclave. I vini spumanti pi noti nelle marche sono Il Verdicchio Dei Castelli di Jesi Classico Brut e la Vernaccia di Serra Petrona. |
|||
|
Il Mosto
I tipi di mosto Tutti pensavate che esistesse un solo tipo di mosto? Invece no, ce ne sono almeno 5 tipi diversi. Il mosto parzialmente fermentato, nel quale la fermentazione gi stata avviata e quindi contiene gi una certa quantit dalcol ma non ancora tale da poter parlare di vero e proprio vino. Mosto concentrato, da questo tipo di mosto stato eliminato il 50-70% dacqua, per fare in modo di aumentare la concentrazione di zucchero, per mezzo del raffreddamento (-13C) o per riscaldamento (100C per 10 secondi) Mosto concentrato rettificato, in questo la percentuale di zucchero sicuramente pi elevata che nel precedente. Mosto muto, a questo stato aggiunto almeno il 12% dalcol, oppure una dose elevata danidride solforosa (oltre 1g/l) questo mosto non in grado di fermentare. Filtrato dolce, si ottiene mediante ripetute filtrazioni, oppure mediante una filtrazione molto fine, per fare in modo da separare i microrganismi (lieviti) responsabili della fermentazione, dal mosto. La pulizia del mosto detta anche sfecciatura Nel mosto, dopo i vari passaggi di torchiatura e sgrondatura, si trovano ancora delle particelle in sospensione (frammenti di foglie e altri residui vegetali, granelli di terra etc) queste costituiscono la feccia e deve essere eliminata prima di qualsiasi trattamento. Loperazione per eliminare queste particelle detta pulizia del mosto o sfecciatura, e si pu eseguire in vari modi, mediante refrigerazione, centrifugazione, chiarificazione e solfitazione. Recentemente adottata unaltra tecnica che detta flottazione, in questo caso le particelle solide sono spostate verso lalto per adesione a bolle di gas, che vengono insuflate appositamente. In realt la feccia tende a depositarsi sul fondo, e il mosto quindi assume un aspetto pi limpido, ma questazione troppo lenta e lesito non sempre soddisfacente. La correzione del mosto Ci sono annate in cui le condizioni climatiche non sono favorevoli e luva non matura completamente e quindi il mosto che si ottiene povero di zucchero e troppo acido, oltre che risultare carente nella colorazione. Si rende quindi necessaria la correzione del mosto stesso. Il grado zuccherino In Italia fatto divieto di aggiungere zucchero al mosto, perci per aumentare il grado zuccherino sono utilizzati metodi indiretti. In ogni caso non si pu aumentare la percentuale di zucchero in proporzione tale che laumento del grado alcolico del vino sia superiore al 2%. Nel caso di un mosto che potrebbe dare un vino con 8% dalcol, lo stesso pu essere corretto fino a dare un vino con massimo 10% dalcol. Ma quali sono i mezzi per la correzione del grado zuccherino? Laggiunta di mosto contenente una percentuale di zucchero pi elevata. Laggiunta di mosto muto o di filtrato dolce.(taglio) Laggiunta di mosto concentrato.(arricchimento) La concentrazione del mosto mediante raffreddamento o riscaldamento. Lacidit Non sempre utile correggere il grado dacidit del mosto. Nel caso deccessiva acidit, non conviene intervenire poich la fermentazione facilitata da un alto livello dacidit, c la possibilit di intervenire direttamente sul vino. Se lacidit del mosto scarsa si sviluppano microrganismi dannosi, perci in questo caso opportuno effettuare una correzione, aggiungendo al mosto lacido tartarico, che lacido pi tipico delluva. Bisogna ricordare che non tutto lacido tartarico aggiunto resta sciolto nel mosto, una parte di esso, infatti, si lega al potassio formando bitartrato potassico che precipita, cio sedimenta, in pratica per aumentare di 1 g/l lacidit bisogna aggiungere 1,2- 1,3 g/l di acido tartarico. Il colore Difficilmente ci si trova costretti ad intervenire per rafforzare il colore del mosto, tranne in quei casi in cui luva sia maturata poco. Nel caso servisse, lunico modo di intervenire aggiungendo mosto pi colorato, che si ricava da uve pi ricche di sostanze coloranti, oppure si avr cura di lasciare le bucce a macerare lungamente nel mosto durante la fermentazione. Nel caso contrario, e vale a dire di colore eccessivo, si pu intervenire trattando il mosto con carbone per uso enologico (massimo 100 g per ettolitro) ben disperso nella massa liquida. Per maggior informazione bene affermare che la Legge consente luso di carbone solo per i vini bianchi. Le sostanze azotate Le sostanze azotate sono essenziali per lo sviluppo dei lieviti che sappiamo, necessari per la fermentazione. Per evitare questinconveniente la Legge consente laggiunta al mosto di solfato e fosfato dammonio, contenenti azoto. VAI A PAGINA <2> |
|||||
|
|
|||||